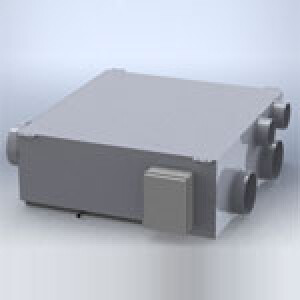Umidità e condensa: quando si forma, perché e come risolvere il problema
Il risparmio energetico nelle strutture edilizie e, di conseguenza, il sempre maggiore isolamento termico degli involucri, sono elementi che hanno acquisito negli ultimi anni un’importanza sempre crescente. Questi aspetti, seppur utili e importanti, portano con sè anche una serie di problematiche che, se non affrontate in modo corretto, possono portare ad una riduzione o perfino all’annullamento dei benefici.
Uno studio poco accurato della stratigrafia delle pareti o degli elementi opachi dell’edificio può portare, infatti, alla creazione di fenomeni quali la formazione di condensa all’interno delle strutture periferiche, la crescita di colonie fungine e/o la presenza di fenomeni di condense superficiali interne alle strutture opache.
Queste problematiche, se non trattate e risolte correttamente, possono causare un danneggiamento dei rivestimenti, una migrazione dei sali presenti all’interno dei prodotti edilizi, formazioni di efflorescenze e quindi una riduzione del grado di isolamento termico dell’involucro.
I fenomeni di questo tipo sono tipicamente riconducibili a:
• Umidità da condensazione: è dovuta a fenomeni di condensazioni superficiali e interstiziali connessi, rispettivamente, alla presenza di superfici “fredde” ed alla diffusione del vapore attraverso la parete;
• Umidità meteorica o accidentale: è dovuta a perdite ed infiltrazioni per la cattiva posa dei materiali o per l’usura subita dal tempo dei prodotti isolanti;
• Umidità da costruzione: è dovuta alla presenza di acqua nei materiali da costruzione;
• Umidità da infiltrazione e ascendente: è dovuta al fenomeno di risalita capillare in murature a contatto con terreno umido o acque di falda molto vicine alle fondamenta.
Normativa
Il DPR 59/09 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), fornisce la seguente prescrizione in merito ai fenomeni di condensazione:
Art.4 comma 17.
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo dell’umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65 per cento alla temperatura interna di 20 °C.
Inoltre, nella legislazione attuale troviamo riferimenti alla verifica termo-igrometrica delle strutture perimetrali (UNI EN ISO 13788 “Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e condensazione interstiziale”). In queste verifiche però non si prendono in considerazione le altre tipologie come le risalite capillari d’acqua o la tenuta all’acqua meteorica.
I fenomeni superficiali
I fenomeni di superficie consistono sostanzialmente nella proliferazione di colonie fungine, e nei casi estremi, anche nella condensazione d’acqua sulla superficie interna dell’involucro.
Il problema nasce quando in un punto dell’involucro edilizio si viene a creare una temperatura inferiore rispetto alle aree circostanti, tale situazione può essere dovuta ad esempio al cattivo isolamento o ad un’errata installazione dei serramenti. Se la temperatura in quella zona è inferiore alla temperatura di rugiada alle corrispondenti condizioni interne di umidità relativa, è molto probabile che in quelle zone si presentino le condizioni ottimali per la creazione di condensazioni superficiali.
Il vapore presente nell’aria interna della stanza, venendo a contatto con la parete fredda si trasforma, portando a cambiare il suo stato (da gassoso a liquido). A parità di altri fattori, la germinazione e lo sviluppo delle spore fungine sui componenti porosi, risultano tanto più rapide quanto più elevata è l’umidità relativa dell’aria locale.
Diversamente, su supporti lisci come vetri o superfici plastiche o metalliche il fenomeno porta solo alla condensazione dell’acqua, senza che vi sia il rischio di germinazione delle colonie.
La soluzione più diffusa in questi casi è sicuramente la correzione dell’isolamento termico al fine di mantenere la temperatura superficiale interna superiore al punto critico di rugiada e, parallelamente, effettuare una corretta ventilazione degli ambienti, per ridurre l’umidità relativa interna.
Le condense interstiziali
I fenomeni di condense interstiziali si presentano prevalentemente durante l’inverno e gli effetti negativi possono determinare un degrado dei rivestimenti, una migrazione dei fluidi presenti nei componenti edilizi con la relativa formazione di efflorescenze saline o subflorescenze.
Questo fenomeno si presenta quando il vapore presente nell’aria tende a spostarsi dall’ambiente con una pressione di vapore più alta (normalmente quello interno) verso l’ambiente a bassa pressione di vapore. La legge di Fick descrive perfettamente questa migrazione, analizzando come la struttura esterna dell’edificio venga attraversata da un flusso di vapore.
Si parla quindi di condensa interstiziale quando un flusso di vapore, attraversando la stratigrafia della struttura trova le condizioni per condensare nell’interfaccia tra uno strato e l’altro.
In presenza di tali casi non è riscontrabile una soluzione generale ma è fondamentale risalire alla composizione esatta della struttura dove avviene la condensazione e cercare di rispettare queste due regole:
• Posizionare il più possibile verso l’interno dell’ambiente gli strati a più alta resistenza al passaggio del vapore;
• Posizionare il più possibile verso l’esterno gli strati con la più alta resistenza termica.
Il primo punto aiuta a ridurre la quantità di vapore che raggiunge gli strati più esterni e quindi più freddi del componente opaco. Il secondo punto serve per mantenere la temperatura dei vari strati interni più alta, in modo che il vapore, mentre li attraversa, non vada incontro a zone fredde e quindi possa condensare.
Va detto però che tramite strumenti come il diagramma di Glaser è possibile studiare soluzioni diverse, permettendo gradi di libertà molto variabili, anche non rispettando queste due regole.
Impianti radianti
L’evoluzione della tecnica ha portato allo sviluppo di sistemi di raffrescamento radianti a pavimento o a soffitto, queste soluzioni per la climatizzazione estiva permettono di raffrescare gli ambienti facendo passare un fluido refrigerato all’interno di tubazioni poste sotto il pavimento. Questo comporta il raffreddamento del pavimento (o del soffitto, nel caso di impianto radiante a soffitto), avvicinandolo alla temperatura di rugiada. Nel caso non vengano effettuati controlli è possibile che si verifichi una condensazione superficiale del vapore acqueo presente nell’aria.
Come soluzione a questo problema, le aziende operanti nel settore hanno introdotto un sistema di deumidificazione neutra, che consente di spostare il limite della temperatura di rugiada a livello superficiale, evitando quindi la condensa.
Il metodo di Glaser
Per studiare i fenomeni di condensazione del vapore all’interno delle strutture edilizie (pareti, solette, ecc.) si utilizza il metodo di Glaser. Questo metodo consente, una volta fissate le condizioni termo-igrometriche interne ed esterne, di verificare se su una struttura piana (supponendo che inizialmente sia asciutta) possa verificarsi la condensazione del vapore acqueo.
La formazione di condensa non pregiudica l’idoneità della struttura, purché la quantità complessiva della condensa alla fine del periodo invernale, sia in assoluto minore o uguale a 500 g/m2 e non ecceda i limiti caratteristici dei vari materiali utilizzati. Nel caso di piccole formazioni di condensa, se si dimostra che la condensa invernale si asciuga completamente nell’arco dell’anno, è possibile comunque considerare la struttura idonea.
Il diagramma di Glaser può essere inteso come un grafico che fa riferimento ad un piano cartesiano, il quale riporta in ordinate la pressione del vapore e in ascisse la resistenza al vapore.
Il metodo si basa sul confronto tra l’andamento della pressione di saturazione e l’andamento della pressione di vapore, fornendo notevoli semplificazioni della complessa fenomenologia fisica del problema, che possono essere riassunte nei seguenti punti:
• il trasporto di umidità unidimensionale in fase vapore;
• non si considera trasporto di umidità associato a moti convettivi di aria umida;
• si considera il sistema in regime stazionario
• l’acqua condensata all’interno dei componenti non si sposta verso le zone più secche.
La norma UNI EN ISO 13788 e il metodo di Glaser rendono possibile il confronto tra le condizioni termo-igrometriche interne ed esterne con i valori medi mensili di tutto l’anno, ottenendo dei diagrammi di diffusione della parete per ogni condizione climatica possibile, prevenendo quindi la formazione di condense pericolose.
In genere, se la quantità di condensa risulta ammissibile, è consigliabile non porre in opera la barriera al vapore. Al fine di aumentare le possibilità di smaltimento dell’acqua condensata è anche possibile prevedere un opportuno sistema di ventilazione meccanica controllata, da installare nella zona interessata alla condensazione.
Definizioni utili
Efflorescenze: si intende la migrazione alla superficie della muratura di sali di vario tipo che, trasportati in soluzione dall’acqua, quando questa evapora a contatto con l’aria, cristallizzano, formando sulla faccia del muro macchie di dimensioni variabili, più o meno aderenti. Spesso non sono che manifestazioni passeggere sulla muratura appena terminata; ma se questa continua a ricevere sali minerali (ad esempio dal terreno, dalle strutture in calcestruzzo retrostanti, da precipitazioni inquinate) possono anche diventare croniche. I danni sono soprattutto estetici, ma in alcuni casi possono disgregare malta e mattoni. Per evitare il loro insorgere occorre controllare i materiali, isolare bene il muro dal terreno, dotarlo, quando possibile, di uno sporto di gronda ed assicurare ad esso un efficace regime di allontanamento dell’umidità.
Subflorescenze: sono un fenomeno analogo alle efflorescenze, cambia solo il punto in cui avviene l’evaporazione dell’acqua e il rilascio dei sali. Se questi avvengono non direttamente sulla pelle esterna dell’edificio ma subito sotto l’ultimo strato (es. intonaco plastico) provocano il distacco di parti esterne con rotture o sbollature.